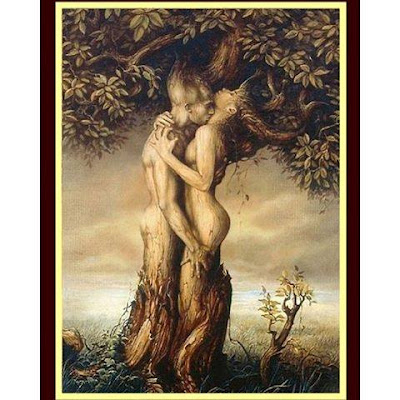giovedì 30 maggio 2019
La cerimonia del te'
Il Cha no yu ("acqua calda per il tè"), conosciuto in occidente anche come "Cerimonia del tè", è un rito sociale e spirituale praticato in Giappone.
La cerimonia del tè è un rito antichissimo dietro al quale si nasconde una vera e propria filosofia di vita. Il tipico tè verde in polvere, il "maccha", arrivò in Giappone dalla Cina nel periodo Kamakura (XII-XIII secolo). Noto per le sue proprietà mediche e terapeutiche, il tè assunse un ruolo importante come elisir di lunga vita.
La leggenda racconta che sia stato addirittura Bodhidharma, un monaco buddista del VI secolo, a creare la pianta del tè: durante 9 lunghi anni di meditazione, per timore di addormentarsi e venire meno al suo impegno, decise di tagliarsi le palpebre, che caddero sulla terra dando vita alla pianta del tè. Il tè in effetti è un mezzo per non assopirsi e mantenere viva l’attenzione e la concentrazione durante le lunghe pratiche di meditazione. Inizialmente il consumo del tè era quindi riservato ai monaci, nei monasteri durante le cerimonie religiose; col tempo si diffuse anche tra l'alta aristocrazia.
Successivamente l'uso del tè si diffuse anche fra i samurai, che fecero della cerimonia del tè un elemento importante della Via, il codice di condotta che regolava la vita dei guerrieri.
Fu un uomo di nome Murata Shukô che trasformò il rito, da un semplice incontro fra amici ad un momento intimo fra poche persone, il padrone di casa e i suoi ospiti. Con lui nacque un rito basato sulla sensibilità Zen, sulla purificazione dello spirito e sul rispetto della natura. Grazie allo Zen è possibile comprendere a fondo i significati nascosti dietro ogni piccolo gesto intorno a cui si costruisce la cerimonia, il raggiungimento dell’illuminazione e le forme d’arte che ne derivano.
La cerimonia del tè fu però resa celebre da Sen no Rikyû, nato nel 1522 nella prefettura di Ôsaka, che ne fece una vera e propria forma d’arte e lo resero famoso in tutto il Giappone, tanto da diventare servitore di Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, due dei tre generali che si batterono per l’unificazione del Giappone fra il 1500 e il 1600. A Rikyû si devono i riti osservati ancora oggi: serenità e sintonia, silenzio e quiete interiore, armonia e natura.
Il rituale della cerimonia del tè si svolge nella "cha shitsu", la cosiddetta stanza del tè, che di solito è eretta separata dal resto della casa o addirittura in giardino. All'interno di essa gli arredi sono rustici e fatti solo di legno e paglia, esempi di purezza e raffinatezza. L’essenzialità, l’assenza di mobili, di apparecchi tecnologici e di qualsiasi altro oggetto o ornamento, è rappresentazione del vuoto a cui la meditazione Zen aspira:l’assenza di contenuto lascia spazio al pensiero e alla contemplazione.
Un elemento essenziale che invece deve essere presente nella stanza è il "tokonoma", una piccola nicchia ricavata nella parete dove vengono appesi rotoli di carta scritti da calligrafi e una piccola composizione di ikebana, chiamata "chabana", spesso costituita da un solo fiore posto in un vaso.
Il posto a sedere vicino al tokonoma è il più importante e quindi riservato al capofamiglia o, a seconda dell'occasione, all’ospite più importante. La disposizione dei pochi ornamenti è generalmente studiata con cura affinché sia in sintonia con le persone, con l’ambiente e la stagione. Anche il giardino riveste un ruolo fondamentale e deve essere curato con tale minuzia da farlo sembrare un lavoro della natura e non dell'uomo.
Il primo momento della cerimonia è quello in cui gli ospiti percorrono il giardino per recarsi al padiglione esterno o alla stanza del tè e rappresenta l'attimo in cui ci si lascia alle spalle la città e la confusione per immergersi nel silenzio e nella meditazione. Percorrendo il giardino gli ospiti si preparano spiritualmente ad uno stato più elevato della vita quotidiana, che un piccolo ruscello, le lanterne antiche coperte di muschio, il profumo di piante e fiori amplificano e favoriscono.
Un altro aspetto importante è l’abbigliamento, solitamente caratterizzato da colori sobri; ai piedi i tradizionali "tabi" (calzini tradizionali giapponesi), tra le mani il ventaglio e nel risvolto del vestito i "kaishi" (fazzoletti di carta bianca).
La cerimonia si svolge nell’assoluto silenzio dei partecipanti, padrone e ospiti, che dopo essersi purificati con l’acqua hanno accesso alla stanza e possono prendere posto sui "tatami" (la stuoia di bambù intrecciato), accanto al padrone in ordine di importanza. Tutto il rito è un insieme di gesti fissi e lentissimi, decisamente misteriosi agli occhi di chi non ne conosce il significato. Si tratta di una vera e propria tecnica di meditazione strettamente legata alle pratiche Zen.
Solitamente la cerimonia si svolge servendo un pasto leggero chiamato "kaiseki" e poi il momento vero e proprio in cui viene servito il tè, prima in forma densa, poi più leggera. Lo svolgimento di tutte le fasi della cerimonia potrebbe richiedere anche alcune ore in cui ogni partecipante osserva rigidamente tutte le regole imposte dal rito.
Il tè viene servito due volte dunque
- la prima volta è denso e corposo ("koicha") e l’ospite più importante lo assaggia per primo; dopo averne bevuto uno o due sorsi passa la tazza al vicino, che fa lo stesso, fino a quando al tazza non giunge all'ultimo cerimoniante, che è il padrone di casa;
- la seconda volta invece il tè è più leggero ("usucha") e ad ogni ospite viene servita una tazza il cui contenuto deve essere bevuto interamente.
In entrambi i casi quando viene offerta la tazza l’invitato la prende con la mano destra e lentamente la appoggia sul palmo sinistro ammirandone la bellezza, poi sempre con la mano destra fa ruotare la tazza in senso antiorario in modo da porgerne il lato più bello verso l’esterno. Dopo aver bevuto e pulito il luogo di appoggio delle labbra la tazza viene nuovamente ruotata e riportata nella posizione iniziale. Al termine della cerimonia le tazze vengono restituite al padrone che le raccoglie e le porta fuori dalla stanza. Al suo ritorno con un inchino egli determina la fine del rito congedando gli ospiti dalla stanza accompagnandoli fuori.
Il tè rappresenta quindi per la cultura giapponese non solo un valore gastronomico ma anche e soprattutto sociale. Dai germogli e dalla prima foglia della pianta si ricava il tè migliore. Il tè verde giapponese viene trattato al vapore così da acquistare un aroma delicato, un profumo leggermente amaro e un colore verde chiaro.
In un Paese fortemente modernizzato e fortemente attratto dai valori occidentali, un antichissimo rito come la cerimonia del tè potrebbe sembrare quindi anacronistico, tuttavia si dimostra come il Giappone sia ancora un paese strettamente legato alle tradizioni.
La bella 'mbriana, lo spirito buono della casa.
Una delle figure più nominate del folclore italiano è sicuramente il "munaciello", o "monaciello" (ma ha davvero moltissimi nomi a seconda della zona e della regione), uno spiritello burlone della casa che se prende in simpatia chi ci vive lascia monete e soldi nascosti negli angoli del'abitazione e se diventa ostico può nascondere oggetti, romp...ere piatti e altre stoviglie e fare scherzi di cattivo gusto.
Nel napoletano però sono presenti altre figure leggendarie, ma tra tutte forse la più importante è la "Bella 'Mbriana", uno spirito benevolo domestico che tutti a Napoli conoscono. Raffigurata come lo spirito di una massaia, la Bella 'Mbriana è la protettrice della casa e leggende vogliono che per ingraziarsela basta semplicemente portare rispetto per la propria abitazione e salutarla quando si esce o si rientra.
Oggi non si usa più, ma i nostri nonni erano soliti salutare la Signora all’ingresso con le parole "Buonasera 'Bella 'Mbriana" e in cambio ottenevano protezione per le loro cose, benessere e salute per chi abitava la loro casa. Sempre per essere gentili con lei erano soliti lasciare sempre una sedia libera in casa affinché la donna potesse sedersi per riposare; al contrario, se queste usanze venivano meno, lo spirito poteva andarsene a causa della mancata ospitalità. Anche l'ordine e l'educazione era un motivo di vanto per quella che potremmo definire la "vera padrona di casa": persone ordinate, miti, sorridenti e gentili erano spesso ricompensate ritrovando sempre gli oggetti che perdevano, con il benessere degli animali domestici e una sensazione di benessere ogni volta che si sedevano su una sedia o una poltrona.
La leggenda della Bella 'Mbriana ha radici molto antiche, che si perdono nei secoli. Il nome deriva da Meridiana, una principessa molto bella che, innamoratasi di un bellissimo uomo dell'alta aristocrazia, ebbe notizia della sua morte in una sanguinosa battaglia per difendere i confini dagli invasori. Non riuscendo a convincersi della morte del suo amato, la ragazza iniziò a vagare per le vie di Napoli bussando ad ogni casa alla ricerca del suo amore, che lei credeva ferito e accolto in una di esse. Il tempo passò e lei cadde in una profonda disperazione che pian piano logorò la sua anima trasformandola in un'ombra, un fantasma vagante nei vicoli della città alla ricerca di qualcuno che non avrebbe mai trovato. Il Re, suo padre, non sapendo come fare per aiutare l'anima inquieta della figlia, decise di ricompensare tutti coloro che, vedendo un'ombra anomala per i vicoli, aprissero le loro porte accogliendola.
Ecco quindi che la Bella 'Mbriana assunse l'identità di uno spirito benevolo che ringraziava chi l'accoglieva con piccoli gesti apparentemente casuali, eppure sempre positivi per chi abitava in quelle abitazioni. Oggi in lacune zone della Campania il suo "culto" è ancora vivo e si crede che nelle case vi sia uno spirito femminile che protegge la famiglia e la casa stessa.
Non è facile descriverne l'aspetto perché lei appare solo per pochi istanti, a volte nel buio dei corridoi, a volte scostando una tenda o aprendo una porta appoggiata. Reste quasi sempre invisibile, ma sa si percepirebbe da qualche riflesso anomalo, dai brividi che a volte ci corrono lungo la schiena, da quelle forme indistinte che a volte vediamo con al coda dell'occhio.
Sempre la leggenda vuole che se la si riuscisse a vedere per qualche attimo, lei si tramuterebbe in farfalla o in un geco, una lucertola che nelle sere d'estate dà la caccia agli insetti vicino alle lampade e che tutti a Napoli rispettano e ritengono che porti buona fortuna; perché chissà, forse è lei, la Bella 'Mbriana, che sotto la luce ci osserva e ci ascolta, perfino quando siamo assorti nei nostri pensieri prima di andare a dormire.
Questa figura è davvero famosissima, tanto che il cognome Imbriani, molto diffuso in Meridione, è proprio nato dalle leggende su di essa; anche Pino Daniele nel suo singolo del 1982 ha voluto omaggiarla addirittura dando come titolo al suo album "Bella 'Mbriana".
La Bella 'Mbriana sempre secondo le leggende locali, è anche piuttosto suscettibile: mai parlarne mai male o lamentarsi quando le cose in casa vanno male e soprattutto mai progettare traslochi ad alta voce perchè rischiereste di scatenare la sua ira che per ripicca potrebbe rivalersi sulla morte di un vostro caro.
Un famoso proverbio recita:
«Casa accunciata, morte apparecchiata»
(casa ristrutturata, morte preparata… in agguato).
Al giorno il progresso, la frenesia sociale, lo stare sempre meno in casa e occuparsene sempre più superficialmente sta facendo scomparire non solo le leggende, ma anche la figura della Signora della casa e gli anziani dicono che ella si manifesti sempre più raramente perché infastidita e impaurita dalla frenesia della vita moderna in cui armonia e serenità familiare sono ormai un lontano ricordo.
domenica 19 maggio 2019
La bolla papale "Ad extirpanda": torturare è lecito.
Il15 maggio 1252 papa Innocenzo IV, nell' ambito della lotta ai movimenti ereticali che furoreggiavano in quel XIII secolo (come per esempio quello della mistica protofemminista Guglielma la Boema, che predicava in Milano), emana la bolla "Ad extirpanda". Con questa bolla il papa autorizza il ricorso alla tortura per estorcere confessioni ai sospetti di eresia, categoria che includeva non solo gli eretici in senso stretto, ma anche coloro che seguivano altre fedi o tradizioni: gente come i catari od i valdesi ma anche streghe, guaritrici, herbane...
Il nome della bolla viene da uno dei suoi passaggi iniziali, dove si legge 《Ad extirpanda de medio populi christiani haereticae pravitatis zizania...》ovvero 《Per estirpare la diffusione nel popolo cristiano della maligna perversione eretica...》 e la sua emanazione segue di poco e non casualmente l'assassinio dell' inquisitore generale di Milano Pietro da Verona, che il 6 aprile era stato ucciso a roncolate in testa nel bosco di Farge a Seveso (Milano) da cittadini comuni e catari esasperati dalla sua spietatezza - per divenire poi santo taumaturgo contro l'emicrania. Era insomma in corso quasi una guerra e non sarebbe del tutto sbagliato dire che le radici della nostra cultura sono cristiane perché se ne avevi altre le bruciavano
(In foto dal web: raffigurazione della diffusissima tortura detta "del tratto di corda" e considerata (dagli inquisitori) lievissima: le braccia venivano legate dietro la schiena ed ai polsi era collegata una fune tesa da una ruota, girando la quale il malcapitato veniva sollevato da terra con conseguente immediata lussazione delle spalle. Ulteriore aggiunta potevano essere i "tratti" ovvero lasciar andare all' improvviso un tratto di corda cosicché la vittima, precipitando ma senza toccare terra, subisse ulteriori dolorisissimi strappi, resi ancora peggiori dall'aggiunta di pesi ai piedi)
sabato 11 maggio 2019
Giunone, regina degli dei
Hera, che i romani chiamarono Giunone, era la regina degli dèi, in quanto moglie di Zeus; figlia di Cronos e di Rhea e come tutti gli altri figli, meno che Zeus, era stata inghiottita dal padre. Fu allevata dalla nutrice, ninfa Macris, nell'isola di Eubea, nella casa della nereide Teti(Thètis). Il matrimonio con Zeus poteva dirsi felice anche se spesso scoppiavano liti furiosi a causa della forte gelosia di Hera, gelosia fondata, aggiungerei. Uno dei litigi scoppiò poco dopo le nozze, ed Hera, fortemente irritata lasciò l'Olimpo e fuggì nell'isola di Eubea a farsi consolare dalla nutrice Macris. Zeus, nel frattempo, non riusciva a darsi pace per la sfuriata della sua sposa e non potendo vivere senza di lei, escogitò uno stratagemma. Scese sui monti di Eubea e fece spargere la voce di un suo prossimo matrimonio con una bella ninfa del paese. Fece fare una donna di legno, la rivestì di abiti sontuosi, la mise su un carro e diede ordine a chi lo guidava di andare percorrendo tutte le strade dell'isola, rispondendo a chi lo interrogasse che egli portava la nuova sposa a Zeus.
Alla notizia, Hera andò incontro al carro e quando si precipitò sulla rivale, le strappò le vesti e si accorse che si trattava di un fantoccio. L'intelligente dea capì la lezione del marito, sorrise e tornò all'Olimpo accanto a lui. Hera veniva raffigurata nel fiore della sua beltà matronale, col viso incorniciato da folti capelli, con lo splendore di occhi grandi, il cui sguardo era dolce e ispirava venerazione. Per lo più veniva ritratta assisa sul trono: con una mano reggeva una melagrana, simbolo del matrimonio e della fecondità, essendo la dea protettrice dei matrimoni e dei parti; con l'altra mano teneva lo scettro sormontato da un cuculo, l'uccello di primavera, in ricordo della forma sotto la quale le si era presentato Zeus quando aveva chiesto la sua mano di sposa. Hera veniva adorata con particolare solennità ad Argo e Samo. Le erano consacrati, oltre al cuculo, la cornacchia e il pavone.
lunedì 6 maggio 2019
Le Sirene – Vampiri nella Grecia Classica
Le sirene non possono essere esattamente definite “vampiri”, ma appartengono, insieme ad altre figure mitologiche che verranno analizzate prossimamente, ad una stirpe di creature ibride e femminili legate alla sensualità e alla morte, all’incanto e alla ferocia. Tutti elementi che giocano sul binomio – quello di amore e morte – tipico del topos del vampiro.
Allo stesso modo dei mostri bevitori di sangue, che sono morti eppure camminano tra i vivi e dunque appartengono ai due mondi, anche queste creature danno prova di grande forza vitale, ma in qualche modo affondano gli artigli nell’Oltretomba.
« Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας
ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται.
ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ
Σειρήνων, τῷ δ’ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,
ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ,
ἥμεναι ἐν λειμῶνι• πολὺς δ’ ἀμφ’ ὀστεόφιν θὶς
ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν »
«Tu arriverai, prima, delle Sirene, che tutti
gli uomini incantano, chi arriva da loro.
A colui che ignaro s’accosta e ascolta la voce
delle Sirene, mai più la moglie e i figli bambini
gli sono vicini, felici che a casa è tornato,
ma le Sirene lo incantano con limpido canto,
adagiate sul prato: intorno è un mucchio di ossa
di uomini putridi, con la pelle che raggrinza »
Omero. Odissea XII, 39-46
La sirena rappresenta due facce di una femminilità non incanalata nei ruoli sociali.
Il suo essere mostruoso la colloca ai margini della società, più precisamente su una linea di confine.
Il confine tra la vita e la morte, ad esempio. Tra l’oriente e l’occidente che è come dire tra ciò che è noto e l’ignoto. Non è un caso che essa sia associata alla dea Aphrodite che è una dea straniera d’oriente per la società ellenica, ma che permea le civiltà pelasgiche precedenti, che di quella ellenica sono state la culla; non è un caso che siano associate alla dea Persefone, a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
Il mito racconta che le sirene fossero presenti al rapimento di Persefone da parte dello sposo Ade. Con la loro presenza testimoniano il passaggio della dea dalla condizione di nymphe, fanciulla, a quella di gyne, donna sposata e regina del mondo dei morti. Ancora si racconta che le sirene siano fanciulle mutate in uccelli dalla dea Afrodite per avere trascurato l’amore: conosciamo la leggenda della sirena Partenope che, fuggita dai propri pretendenti, si tagliò i capelli e si rifugiò nel golfo di Napoli da cui la città prese il nome.
Il culto di Aphrodite e quello di Persefone sono molto legati l’uno all’altro e vengono separati anzi soltanto in un momento più tardo. Si trattava probabilmente del culto di due diversi aspetti di un’unica dea di cui la sirena era animale di riferimento.
A conferma di ciò, secondo Pausania, i templi delle due dee sorgevano l’uno di fronte all’altro, legittimandole come riflesso l’una dell’altra.
Le attività all’interno dei templi vedevano le ragazze impegnate nella musica, che aveva una grande importanza: quindi nel canto e nella danza rituale, per onorare e rendere servizio alla dea, e in mansioni che le avrebbero preparate all’ingresso della comunità cittadina come spose. Passaggio simboleggiato dal rapimento del marito che sarebbe venuto a prenderle al tempio come Ade con Persefone o Teseo con Arianna ed Elena.
La sirena è dunque l’icona di questo periodo della vita della fanciulla, della stagione selvaggia, non addomesticata dalla vita matrimoniale e dalla maternità. Come le ninfe, le sirene occupano il territorio simbolico dell’energia sessuale pura e incontaminata.
Simboleggiano il crocicchio, il passaggio: dall’infanzia all’età adulta a quello più grande e misterioso, dalla vita alla morte. Sono la zona di frontiera tra l’umano e il ferino.
« La brezza favorevole spingeva la nave, e ben presto avvistarono
la splendida Antemoessa, isola in cui le canore Sirene,
figlie dell’Acheloo, annientavano chiunque
vi approdasse, ammaliandolo coi loro dolci canti.
La bella Tersicore, una delle Muse, le aveva generate
dopo essersi unita all’Acheloo; un tempo erano ancelle
della potente figlia di Deò, quando ancora era vergine,
e cantavano insieme con lei: ma ora apparivano in parte
simili a fanciulle nel corpo e in parte ad uccelli.
Sempre appostate su una rupa munita di buoni approdi,
avevano privato moltissimi uomini della gioia del ritorno,
consumandoli nello struggimento. Anche per gli eroi
effusero senza ritegno le loro voci, soavi come gigli,
ed essi già stavano per gettare gli ormeggi sulla spiaggia:
ma il Tracio Orfeo, figlio di Eagro, tendendo la cetra
Bistonia con le sue mani, fece risuonare le note allegre
di una canzone dal ritmo veloce, affinché il suono
sovrapposto della sua musica rimbombasse nelle loro
orecchie. La cetra vinse la voce delle fanciulle: Zefiro
e insieme le onde sospinsero
la nave, e il loro canto si fece un suono indistinto. »
Apollonio Rodio. Argonautiche IV, 890-912
Il mito le vuole nate dal sangue sgorgato da un corno del dio del fiume Acheloo, raffigurato con la testa di toro. Il sangue versato da Eracle feconda la terra, facendo nascere le divine cantrici.
Altre tradizioni le vogliono figlie di Forco, divinità marina padre tra gli altri delle Gorgoni, delle Graie, di Ladone, Scilla e della terrificante Echidna.
Sappiamo dall’iconografia che si tratta di creature ibride, donne uccello. Se da una parte sono creature spezzate, né umane né uccelli, esse sono anche un intero che non ha riscontro in natura: appartengono al sacro.
Nelle mitologie di tutti i popoli venivano venerati simili ibridi femminili: donne uccello, donne pesce e donne foche, perfino donne rana e donne serpente. Tutte espongono i seni, il ventre o la vulva e tutte sono manifestazioni della sensualità divina femminile.
Nelle fonti greche più antiche sono raffigurate come grossi uccelli dal volto umano per poi acquisire con il passare del tempo braccia e mani con cui tenere gli strumenti musicali: l’aulòs (il flauto a due canne il cui suono era detto simile al canto della sirena), la lira o ancora la siringa (flauto a più canne legate insieme a formare una zattera, detto anche flauto di Pan). Tutti strumenti legati ai misteri dionisiaci, al canto e alla danza femminile.
L’origine del nome di queste creature marine è incerta: si potrebbe risalire al greco seiren, “che sorge dalla pianura”, perché erano il simbolo della piana e lucida superficie del mare, sotto la quale stavano coperti gli scogli e i banchi di sabbia. Oppure, sempre al greco seirios, incandescente o deteriorabile, a seraphin, ardere. Da qui a selas che significa splendente, ardente, lume. Da selene invece ci colleghiamo a luna. Possiamo immaginare l’ardere del sole del mezzogiorno, della canicola, della bonaccia dei mari dannosa quanto la tempesta.
Si cerca l’etimologia anche nel greco syro, attraggo; seirao, incateno, come i marinai prigionieri dell’incanto, legati alle sirene come i naviganti legano a sé i vascelli. Oppure ancora nell’ebraico sir o scir, suonare. Il greco syrigs sta per suonare la siringa, ma anche per sussurro. In latino e nelle lingue romanze le troviamo chiamate serene, in relazione alla parola serenus, asciutto, senza nuvole, cielo chiaro e disteso, rispecchiante il mare calmo sul quale apparivano.
Le sirene vengono spesso raffigurate in gruppi di tre, ognuna con uno strumento sacro, oppure alle due suonano si accompagna una terza che canta.
Nell’Odissea abitano un campo fiorito di un’isola e incantano i marinai al loro passaggio. Come molte creature idriche (le ninfe dei mari, dei fiumi e delle sorgenti) vivono nei luoghi in cui terra e acqua si incontrano: la riva del mare, gli argini di un fiume o le paludi, dove i due elementi si fondono l’uno nell’altro. L’acqua è l’elemento in cui vivono, ma che anche delimita il confine tra il loro mondo e quello della società, che è invece terrigno, organizzato, razionale.
Il confine tra il mondo conosciuto e l’ignoto.
Quello delle sirene è un culto antico che affonda le sue radici nella civiltà matriarcale agricola, legata alla terra e ai suoi segreti ctoni e tellurici. Se la Grecia classica le ingloba dando loro ruoli marginali e poco edificanti nell’economia del divino sostenuto dagli Olimpi, in alcuni luoghi il loro culto sopravvive al susseguirsi delle civiltà, dopo le prime colonizzazioni greche del Tirreno meridionale. Lungo la costa italica, in prossimità delle antiche rotte di colonizzazione, li riconosciamo lungo la costa sorrentina in un gruppo di isole chiamate Sirenusse, o presso lo Scoglio delle Sirene. In queste aree erano molti i santuari preposti alla loro cura. Si venerava perfino la “tomba della sirena” in memoria di colei che, secondo la leggenda, non essendo riuscita a sedurre Odisseo, si gettò in mare dallo sconcerto.
In questi luoghi era venerata in particolar modo la triade conosciuta con i nomi di Partenope (Voce di Vergine), Ligeia (Voce Chiara) e Leucosia (Dea Bianca). Tra gli altri nomi di sirene che ci sono pervenuti, dai quali si desumono spesso anche le qualità delle loro voci, si parla anche di Ciana (l’Azzurra), di Himeropa (Colei che Provoca il Desiderio) il cui nome subisce un adattamento posteriore nel tempo in Eumolpe (Colei che Canta Bene) e poi ancora in Molpo (L’Armoniosa).
Una seconda terna sembra essere definita da Aglaope o Aglaphonos (La Squillante), Telxièpeia (Canto che Addolcisce) e Pisinoe (la Suadente).
Una dicotomia importante vede contrapporsi le muse elleniche alle sirene e concludersi con la sconfitta di queste ultime a rappresentare la supremazia di una civiltà nuova su quella più antica.
Se le muse cantano per gli dèi, le sirene cantano per gli uomini. Se le prime rispecchiano la bellezza, la perfezione e l’armonia apollinea dell’arte, le seconde hanno tratti più foschi, più sinistri e di perdita di sé nel rituale dionisiaco: ma non sono che facce della stessa medaglia.
Secondo Pindaro (Peana 8) pare che a Delfi, prima del tempio in pietra, ne fossero stati costruiti altri tre: una capanna di rami di alloro; uno di cera d’api e piume d’uccello che poteva volare e che lo fece, scomparendo nella mitica, lontana terra degli Iperborei; un terzo di bronzo costruito da Atena ed Efesto sul cui fronte cantavano le Keledones, sei cantatrici (e incantatrici) d’oro. Statue viventi di splendide fanciulle dai tratti di uccello. Secondo la leggenda, gli Olimpi distrussero quest’ultimo tempio sprofondandolo in una voragine della Terra perché il canto delle Keledones causava negli esseri umani l’oblio, facendo loro trascurare le occupazioni quotidiane e la cura della famiglia e della casa. Prima che venisse distrutto, in questo tempio venivano custodite, appese al soffitto come uccelli, delle iynges d’oro. Si trattava di strumenti di magia dalla forma di una ruota che venivano fatti vorticare su una cordicella tesa alle estremità. Pare che la iynx fosse uno strumento inventato da Aphrodite per attirare l’amore verso chi lo usava e instillare il desiderio.
Sovrapporre le iynges e le sirene è giocoforza.
Storicamente il culto di Apollo si insediò a Delfi sottomettendo una preesistente civiltà legata al culto matriarcale della terra. Il mito delle Keledones dal canto perturbante precipitate agli inferi rappresenta molto probabilmente la supremazia sull’antica civiltà in favore di quella nuova e il canto delle sirene fu tramutato in quello delle Muse.
Le sirene erano divinità legate al mare, alla costa e alle condizioni climatiche e venivano onorate come demoni benevoli a tutela dei naviganti nei bracci di mare pericolosi.
Se nella Grecia orientale le raffigurazioni delle sirene continuano ad essere scarse e legate al loro aspetto più ctonio e funereo, nell’arte greca occidentale popolano invece l’iconografia concentrata particolarmente sul lato della sensualità.
Come si è accennato, le fonti, in primis l’Odissea che rimane la più antica testimonianza letteraria a citare queste creature, mostrano le sirene in qualità di cantrici.
Il canto rappresenta la seduzione primordiale, non a caso si parla di in-canto o di in-cantesimo. Quello del canto è la seduzione della parola che canta e incanta.
Se Platone paragona la musica delle sirene all’eloquenza di Socrate, dalla quale bisogna mettersi in salvo per non restare imprigionati dalle sue maglie, Pitagora sostiene che la musica, sorella dell’astronomia, regola le stelle: il loro decorso, il ritmo, l’ordine, l’accordo. Gli astri risuonano armonia e la musica umana non è che l’imitazione.
Il canto delle sirene dona a chi lo ascolta piaceri che sconvolgono, capaci di appagare ogni fame e ogni appetito. Cantando esse inducono all’oblio, provocano la morte nell’incauto viaggiatore che le ascolta riducendolo all’impotenza oppure sbranandolo come le fiere più spietate.
All’incontro con le sirene si può solo soccombere nell’oblio, oppure comprendere il loro canto per elevarsi fino a loro: ferme sul confine, attendono l’iniziato per un percorso spirituale.
Per anni e in molte tesi si è dibattuto sul significato del canto delle sirene. Le interpretazioni più fondate portano a pensare che esso sia collegato alla sfera rituale, a un culto agrario che vedeva le sirene come protettrici degli elementi e intermediarie tra i vivi e i morti, tra il mondo umano e quello divino.
Attraverso la voce esprimono i due aspetti più peculiari della loro natura: il canto della sensualità irrefrenabile e quello funebre dell’Oltretomba.
Dal VI secolo in Asia Minore e dal IV in Attica diventa d’uso porre delle statue di sirena nell’atto di produrre musica sulle tombe o a segnacolo di luoghi preposti alla sepoltura. Il canto di queste creature simboleggiava il canto funebre della cerimonia che aveva come compito quello di accompagnare il defunto nel suo viaggio verso l’aldilà. Secondo la leggenda, le sirene vivono nell’Ade e con la loro musica allieta gli spiriti nobili dei Campi Elisi. Allo stesso modo il loro canto poteva mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti e recare consolazione a chi subiva un lutto.
La natura perturbante di queste femmine ctonie si associa alle lamie, alle empuse, alle onoscelee e alle arpie. Dei parallelismi forti li troviamo anche nella semitica Lilith, demone della lussuria, ma anche del vento e della tempesta. Tutte queste creature sono accusate di rapire bambini o ucciderli nel sonno; tutte sono coinvolte in una maternità negata.
D’altra parte il canto delle sirene poteva eccitare le tempeste, le burrasche e l’impeto del mare. (Pindaro, Partenio 2, frg. 94 b) O poteva controllarle, riportare alla normalità il vento, la furia delle onde e gli altri elementi naturali.
A quale Musa devo rivolgermi con lacrime, con canti funebri o con gemiti di lutto?
Fanciulle alate, vergini figlie della Terra, Sirene, unitevi al mio lamento
portando il flauto libico, la zampogna di Pan o le cetre
rispondete con lacrime alle mie grida lugubri; dolori con dolori, canti con canti.
Elena, Euripide, v.168
Se da una parte sono creature incapaci di procreare e pronte a rapire bambini umani e a divorare gli uomini per trascinarli negli abissi, dall’altra offrono una sensualità tutt’altro che sterile, ma feconda e piena di vita.
L’aura erotica delle sirene viene espressa dal seno florido, dai gioielli preziosi e dai capelli intrecciati e ornati con nastri: un’immagine che la associa senza difficoltà alle etere. Attraverso la spiritualità orfica alla sirena viene attribuito il significato dell’immortalità dell’anima, della comunicazione con il divino e nella riunione con esso dopo la morte del corpo, attraverso un percorso di purificazione. Numerose sirene compaiono su oggetti di appannaggio femminile, in particolare sui vasi di corredi nuziali delle giovani spose insieme ad Afrodite, al cui seguito appartenevano, e agli eroti. Compaiono sugli specchi e sui pettini, ancora ad affiancare Dioniso e i satiri, spiegando come con il matrimonio si perpetui un rinnovamento della vita rappresentato da Dioniso smembrato e in seguito risorto.
Raffigurate sugli specchi delle fanciulle, spesso ne possiedono uno esse stesse: reggono uno specchio rotondo, come la dea Afrodite alla quale assomigliano (il simbolo astrologico di Venere è lo specchio rotondo che sormonta il manico a croce, del resto, e in genetica lo stesso simbolo indica il femminile). Lo specchio rimanda alla superficie dell’acqua e mostra l’abisso. Oppure lo illumina, come lo specchio del pescatore.
Le sirene, come Afrodite, si specchiano. Studiano loro stesse, si indagano, vanno in profondità, cercano la conoscenza sotto la superficie. Allo stesso modo, abbagliano il navigante che giunge fino a loro: lo illuminano, gli mostrano la verità.
Il pettine che usano serve a ravviare la lunga chioma ondulata, che rimanda al mare, al moto ondoso e alla stessa luce, che illumina.
Sono creature della seduzione: seducere significa condurre a parte, trarre in disparte, far deviare, dirottare. Sono quindi creature che costringono al cambiamento. Il loro è un segreto rituale, dal momento che “cosa seduce” non è palese, ma resta nascosto.
Rappresentano il femminile oscuro e acquatico. Quando le si ascolta, lo si fa al di là dei sensi, in una dimensione interiore.
Medea nel paese delle streghe di Pietro Citati
O sono come fantasmi, ombre, anch’esse inconsistenti. O come sogni, o come fumo. Non hanno più energia, né coscienza vitale, né intelligenza, né sangue, né memoria, né speranza. Quale oscuro desiderio di vita le inquieta, quale nostalgia di essere nuovamente come noi, di parlare con noi, di camminare con noi, di stringerci al petto. Sognano soltanto il latte, il miele, il vino, l’acqua, il sangue, che darà loro, per qualche ora, l’apparenza di esseri umani. L’estremo Oriente, verso il quale muovono gli Argonauti, è il regno di Elios, il Sole: «il multiveggente padre degli occhi» , l’infaticabile auriga, l’instancabile testimone, che vede e ascolta tutte le cose. Ogni mattina Elios si leva nel Paese dell’aurora: la Colchide— la Georgia di oggi. Tutto vi sovrabbonda e trabocca d’oro, che è il segno trionfale del Sole. Il palazzo è pieno d’oro; così le stalle, dove la notte vengono rinchiusi i cavalli, che una volta hanno rischiato di ardere il mondo: il simbolo della regalità è l’oro; i fiumi e i corsi d’acqua sono pieni d’oro, che i Colchi raccolgono con pelli di montone. Anche gli esseri umani, o semidivini, sanno d’oro, il quale è vita e linfa. Il re Eeta, figlio di Elios e protetto da Ares: Circe, sorella di Eeta, che non sappiamo quando e per quale ragione è fuggita verso Occidente, nell’isola boscosa di Eea, dove tesse cantando «un ordito sottile, pieno di grazia e di luce» ; Medea e Apsirto, figli di Eeta, hanno un dono in comune: il lampo degli occhi, che brillano e irradiano davanti a loro «fuochi simili a quelli dell’oro» . Sebbene riempia di luce e d’oro i palazzi, i fiumi e gli occhi, il Sole ha un rapporto segreto con tutto ciò che, nell’universo, è tenebroso, infernale, stregonesco. Quando hanno superato il Capo Acherusio, gli Argonauti incontrano nel Mar Nero la grotta dell’Ade, avvolta da rocce e foreste: senza tregua essa esala dal profondo un soffio gelido, che «tutt’intorno crea la candida brina» . Lì vicino, il fiume Acheronte si getta nel mare. Non sappiamo (o almeno non so) se questo Ade e questo Acheronte siano gli stessi che Ulisse ha incontrato nel suo viaggio notturno: o se invece esista un secondo Ade, un secondo Acheronte, di cui non abbiamo nessuna notizia precisa. In ogni caso, se gli Argonauti vogliono raggiungere il Paese del Sole, devono oltrepassare il mondo della morte. La Colchide è un paese di draghi e di streghe. Il più possente tra questi draghi occupa il bosco di querce sacro ad Ares. Esso è figlio della terra fecondata dal sangue del mostro Tifone: un fuoco feroce gli brucia negli occhi glauchi; tre lingue gli vibrano in bocca; il corpo, coperto di scaglie, è tortuosissimo, tutto volute, spirali ed anelli, che si muovono e si agitano di continuo; soffia terribilmente; e questo soffio risuona lungo il fiume Fasi e nella foresta, tenendo nel terrore i Colchi. Appeso ad una quercia, sta il vello d’oro di un ariete. Grande come la pelle di una giovenca, emana una luce simile a quella della luna piena, che si confonde con il rosseggiare degli occhi del drago. Esso incarna la sovranità regale di Eeta e della sua famiglia. Con le sue fila di denti acutissimi, il drago tiene stretto il vello d’oro nelle mascelle: lo sorveglia giorno e notte, senza addormentarsi mai, perché mai il talismano della regalità deve abbandonare la Colchide. Come la Tessaglia, la Colchide è il Paese della stregoneria. La sua regina è Ecate, signora lunare dei morti e della magia, che si aggira nella notte coperta da un abito nero. Il suo capo è cinto da serpenti, intrecciati con rami di querce, le sue fiaccole lampeggiano: intorno ululano i cani infernali; e le erbe tremano al suo passaggio, mentre le Ninfe delle paludi gettano un grido. Se Ecate si nasconde, la sostituisce Medea, che secondo una tradizione è sua figlia. La luna è il suo astro. Quando rifulge pienissima guardando la terra, nel cielo c’è una quiete profonda, che scioglie in un solo brusio le voci di uomini, uccelli e fiere: le fronde silenziose sono immobili; l’aria umida tace; e solo le stelle hanno un palpito. Medea esce dal palazzo di Eeta a piedi nudi, con la veste slacciata, le spalle coperte dai capelli sciolti e avanza sola, nel silenzio di mezzanotte. Tende le braccia verso le stelle, gira tre volte su se stessa, tre volte si bagna la chioma, tre volte schiude le labbra. Piega il ginocchio a terra, innalzando alla notte l’inno più dolce, molle e affascinato che il mondo classico abbia mai inteso. «Notte, fedelissima ai sortilegi, astri splendenti, raggi della luna, Ecate dalle tre forme, che vieni in aiuto alle formule e alle arti dei maghi, e tu, o Terra, che ci insegni erbe potenti, e voi brezze e venti e monti e fiumi e laghi, e voi, dei delle foreste e della notte, assistetemi» . L’immenso vocativo alla Notte e alla Terra culmina con l’enumerazione delle arti di Medea. «Col vostro aiuto, quando voglio, i fiumi ritornano alla fonte, fermo il mare mosso, muovo il mare fermo, scaccio le nuvole, ammasso le nuvole, scateno i venti, richiamo i venti, apro le fauci delle vipere, vivifico i sassi e li muovo, induco i monti a tremare, tiro la luna giù dal cielo, irrigidisco il corso delle stelle, faccio impallidire il carro del sole, fiorire la terra in piena estate, riempire di luce le foreste più ombrose, colmare di messi la terra in pieno inverno. Ringiovanisco i corpi stremati dei vecchi, diffondo filtri e farmaci e un sopore che addormenta e blocca ogni cosa» . Quando canta il suo canto di strega, Medea sembra una ragazza, una tenera Nausicaa: eppure la sua mente non inorridisce davanti a nessuna visione, il suo animo non teme di compiere nessun delitto. Su in alto, in fondo alla Colchide, sta il Caucaso, «elevato sino al gelo dell’Orsa» , al quale è ancora incatenato Prometeo. Mentre percorrono il Mar Nero, gli Argonauti vedono l’aquila, «il cane alato di Zeus» , volare alta sopra la nave, sconvolgendo le vele col battito delle ali e gettando uno stridore acuto. Poco dopo, dietro le rocce, odono il lamento di Prometeo: l’aquila morde il suo fegato, lo strazia e lo divora; l’aria risuona di gemiti; finché l’aquila si scaglia di nuovo sulla sua vittima indifesa. Il sangue di Prometeo cola a terra sulla montagna; e da quel sangue nasce un fiore alto, che ha il colore dello zafferano, un doppio stelo, e la radice come carne viva. Medea taglia la radice: Prometeo è legato al fiore, che è ancora una parte del suo corpo, e geme, angosciato dalla sofferenza. Dalla pianta Medea trae un filtro nero, che ricorda il succo delle querce, e lo chiude in una conchiglia del Caspio. Così anche Prometeo, la vittima colpevole di Zeus, collabora alle arti della magia. ***Nei tempi antichissimi, Zeus sventò, in Beozia, un crimine orrendo. Nel Paese, per colpa di Ino, la seconda moglie del re Atamante, si era diffusa la carestia: Atamante fece consultare l’oracolo di Delfi; e un falso messaggio decretò che la sterilità della terra sarebbe cessata, se si sacrificava a Zeus Frisso, figlio di Atamante. Mentre stava per uccidere il figlio, intervenne Eracle, che gli strappò dalle mani il coltello sacrificale. «Il padre mio, Zeus— disse— odia i sacrifici umani» . In quel momento, Ermes inviò dall’Olimpo, per ordine di Zeus e di Era, un ariete alato e dorato. Frisso salì sull’ariete, che attraversò i cieli sopra la Grecia, l’Ellesponto, il Mar Nero, fino a giungere nella Colchide. Il re Eeta accolse Frisso, offrendogli la figlia in sposa. In segno di gratitudine e venerazione, Frisso sacrificò a Zeus l’ariete, che salì vertiginosamente in cielo, diventando una costellazione: la costellazione che porta il suo nome. Quanto al vello d’oro, lo offrì a Eeta: come se soltanto un re solare potesse conservare e difendere il talismano dorato della regalità. Zeus voleva che il vello d’oro ritornasse in Grecia, assieme all’ombra di Frisso: solo allora il sacrilegio di Atamante sarebbe stato cancellato e la Beozia avrebbe conosciuto una nuova prosperità. Giasone, figlio di Esone, re della Tessaglia, accolse il suggerimento di Zeus, invitando i più famosi eroi della Grecia, tra i quali Eracle ed Orfeo. Atena costruì, o fece costruire, Argo, la prima nave della storia. Era una nave magica, di cui una trave, appartenuta alla quercia di Dodona, aveva il dono della parola e della profezia. Tutto avveniva sotto la protezione degli dei: eppure la costruzione di Argo ferì a morte l’età dell’oro, quando gli uomini non solcavano i mari sconvolgendo la quiete originaria del mondo. La nave partì verso le rive orientali del Mar Nero. Il viaggio fu lungo e faticoso, pieno di avventure, rischi e pericoli: ma Argo avanzava rapida, con le vele che si gonfiavano al vento, come «lo sparviero avanza veloce nell’alto, con le ali aperte e ferme nel cielo puro» . Giasone raggiunse la Colchide e la foce del fiume Fasi, che si avventava furiosamente nel mare. Quando si addentrò nel fiume, vide un filare di pioppi e la tomba di Frisso. «Per il sangue — gridò — per i dolori che ci congiungono, Frisso, fammi da guida in questa impresa, ti supplico: su questi lidi, proteggimi…» . Infine, Giasone incontrò Medea. Non sapeva nulla di lei. Non sapeva che, in leggende antichissime, era stata una dea madre, una dea ctonia, forse l’ipostasi di Demetra. Non sapeva nemmeno che Era e Afrodite volevano che Medea si innamorasse di lui. Mentre i due si incontravano, Eros tese il suo arco, scagliando una «freccia intatta, apportatrice di pene» , e si insinuò in segreto nel cuore della ragazza. Afrodite tentò un incantesimo per mezzo del torcicollo, l’uccello del delirio amoroso: legò le ali e le zampe dell’uccello ai raggi di una ruota mobilissima, rivolta verso il cuore di Medea, mentre pronunciava formule magiche. Giasone non vedeva in Medea nulla di divino e di stregonesco: scorgeva soltanto una ragazza con gli occhi luminosissimi, che irradiavano «fuochi simili a quello dell’oro» . Quanto a Medea, che conosceva quasi tutte le cose, ignorava la passione d’amore. Quando vide per la prima volta Giasone, fissò su di lui uno sguardo obliquo, scostando il velo che le copriva il volto: il viso, gli abiti, le parole e i gesti di Giasone la affascinarono per sempre. Il volto di Medea arrossiva e splendeva di gioia. Il cuore le batteva in petto, acceso da una fiamma incancellabile. Temeva che lui morisse; e lo piangeva come se fosse già morto. Ma non si abbandonava alla passione, perché la sua coscienza acutissima non smetteva mai di sorvegliarla. Era divisa, separata. Il desiderio, la vergogna, il pudore, il fortissimo senso di colpa, si combattevano nel suo animo. I sentimenti si alternavano e oscillavano. Non conosceva requie. Ora temeva che Giasone fuggisse, tornando in Grecia. Ora voleva fuggire con lui, come sua sposa. Ora non voleva abbandonare il padre, la sorella, il fratello, Ecate, il Sole. Il matrimonio le sembrava un delitto: l’amore una terribile colpa. La notte, quando il silenzio possedeva la terra, Medea si rifugiava nella sua stanza. Non dormiva. Non poteva dormire. Il cuore le batteva fitto, quando pensava ai pericoli o alla fuga di Giasone. Il petto si agitava: versava dagli occhi lacrime di desiderio e di compassione, la pena la rodeva senza riposo, insinuandosi sotto la pelle, fino ai nervi sottili, fino all’estremità della nuca, dove penetra il dolore più acuto. Le sembrava che la luna — la sua luna — le dicesse: «il dio del dolore ti ha dato Giasone come pena e angoscia. Va’ e preparati a sopportare infiniti dolori» . Poi le passavano nella mente tutte le dolcezze dell’esistenza, i piaceri che toccano ai vivi, le compagnie gioiose della giovinezza, e il Sole appariva più dolce ai suoi occhi. Vedeva la soglia brillare di un esile filo d’aurora. La prima luce la confortava, «come un’esile pioggia rialza le spighe inclinate» . Quando Eeta fissò il giorno della prova, Medea unse con l’ «unguento di Prometeo» la lancia, lo scudo e il corpo di Giasone, che diventò invulnerabile. I tori coi piedi di bronzo furono sottomessi senza fatica: i guerrieri nati dai denti dei serpenti si uccisero a vicenda, mentre Medea recitava l’ultima formula. Infine, giunse il giorno della fuga. Medea fissava la strada, ascoltando i rumori della notte. Quando Giasone apparve, le sembrò Sirio — l’astro bellissimo e sinistro —, alto sopra l’Oceano. I due stavano l’uno vicino all’altra, muti e senza parole, «come le querce e i grandi pini, che hanno ferme radici nelle montagne e stanno, senza vento, vicini ed immobili» . Tenevano gli occhi fissi per terra. Poi si guardavano sorridendo e non sapevano quali parole pronunciare, perché volevano dire tutto in una parola sola. Lì vicino stava il bosco sacro di Ares. Il drago tendeva verso loro il collo lunghissimo e le sue enormi volute, soffiando ferocemente. Medea parlò «con voce soave» : la sua voce di strega virginale. Invocò in aiuto «il sonno onnipotente» , perché affascinasse la fiera; e Ecate, la regina notturna, la madre. Intinse un ramo di ginepro nel filtro, e lo sparse sopra gli occhi del drago, mentre diceva le sue formule magiche. Il drago si addormentò. La bocca cadde a terra. Gli anelli si stesero nella foresta. Intanto Giasone staccava dalla quercia il vello d’oro, che faceva luce come un raggio di luna piena, arrossandogli le guance e la fronte. Quando Medea e Giasone arrivarono tra gli Argonauti, l’aurora cominciava appena a bagnare la terra. Medea sedette sulla poppa di Argo; e mentre la nave correva verso la Grecia, si slanciò indietro, tendendo, disperata, le mani verso la patria abbandonata. Alla foce del Danubio, la nave di Colchi guidata da Apsirto, il fratello di Medea, raggiunse quella degli Argonauti. Medea trasse il fratello in un agguato. La vergine dagli occhi d’oro si trasformò: il profondissimo senso di colpa, che nutriva verso il padre, chiese altre colpe, altri delitti. «Rifletti — disse a Giasone —: è necessario, dopo le cose orribili che abbiamo compiuto, pensarne un’altra, ancora più orribile» . Giasone colpì Apsirto con la spada nuda. Medea distolse gli occhi: Apsirto cadde in ginocchio; e mentre esalava l’ultimo respiro, raccolse con le mani il sangue della sua ferita, e arrossò il bianchissimo velo e il bianchissimo peplo della sorella. In quel momento, si risvegliò l’Erinni spietata, signora del mondo, regina del delitto, della punizione e della vendetta; e indusse Medea a moltiplicare i delitti e le colpe. Medea diventò l’Errante, la Straniera, la Leonessa, la Barbara. Quando giunse a Corinto fece uccidere dai propri figli la seconda moglie di Giasone; e li maledisse e li uccise. Poi salì sul suo carro trainato dai draghi alati: vi caricò i cadaveri dei figli e ritornò tra i draghi, le streghe, l’oro, il Sole della Colchide, il vento gelido del Caucaso.
Le versioni di Esiodo ed Euripide
La storia di Medea e degli Argonauti, di cui ho raccontato una parte, è un mito antichissimo, che risale probabilmente all’età micenea. Ispirò una vasta letteratura: una parte della Teogonia di Esiodo (Bur), la quarta ode pitica di Pindaro (Fondazione Valla -Mondadori), la Medea di Euripide (Bur), la Medea di Seneca (E. S. T.), le Argonautiche di Apollonio Rodio (Bur), le Argonautiche di Valerio Flacco (Bur), versi, prose, ricordi dei mitografi, come Igino (Adelphi) e lo pseudo-Apollodoro (Fondazione Valla -Mondadori). In questi giorni è uscito il quarto volume delle Metamorfosi di Ovidio (Fondazione Valla -Mondadori, a cura di Gioachino Chiarini e Edward Kenney, pagine LXXII-484, e 30): dove la storia di Medea viene mirabilmente intrecciata con quelle di Cefalo e Procri, Scilla, Dedalo, Icaro, Meleagro, Bauci e Filemone, Eracle, Io, Minosse
Freya, la signora dei miti nordici
Nella mitologia nordica, si trova Freya, il cui nome significa semplicemente “la Signora”, dea dell’amore e della bellezza. Veniva invocata per incantesimi d’amore o di passione, ed era legata all’intuizione e alla divinazione. Ella era patrona anche della guerra e della morte: dopo ogni battaglia Freya e Odino si dedicavano alla raccolta delle anime dei morti e coloro che venivano scelti da Freya erano condotti alla sua dimora eterna, ove partecipano a feste rallegrate da musica, arti e dall’amore. Tra i suoi animali totemici troviamo, tra l’altro, i gatti: ella ha due gatti alati che tirano il suo carro Betulla, i quali si dice che dopo sette anni venissero liberati e trasformati in streghe (onde per cui si credeva presso le popolazioni nordiche che le maghe e le streghe avessero il dono di mutarsi in gatte).
Il Mito di Iside
Il mito racconta che Seth, arrabbiato fin dalla nascita, è invidioso del potere del fratello Osiride, che è succeduto a Ra ed è divenuto re dell’Egitto. Un giorno Seth dà un banchetto in onore del fratello e fa arrivare una bellissima cassa di legno oblunga. Seth sfida i partecipanti a sdraiarcisi dentro: colui che ci starà perfettamente, sarà il vincitore. Nessuno però sembra essere delle dimensioni giuste fino a quando non tocca a Osiride: a lui la cassa calza a pennello! (Certamente, perché Seth l’ha fatta costruire proprio su misura per lui). Non appena Osiride si sdraia nella cassa, Seth chiude il coperchio e la getta nel Nilo, decretando che la cassa sarà la sua tomba.
Iside, piangendo la morte dell’amato, parte alla ricerca della cassa per garantirgli almeno un funerale appropriato. Per trovarla viaggia fino a Byblos, in Fenicia, dove, lavorando sotto mentite spoglie come nutrice del figlio della principessa, viene a scoprire che la tomba del suo sposo si trova all’interno di un albero di tamarindo attorno a cui il re ha fatto costruire il suo palazzo. Rivelando la sua identità divina in seguito a varie vicissitudini, Iside ottiene dal re il permesso di recuperare la cassa con il corpo dell’amato e di riportarla in patria, dove la nasconde in una palude.
Ma Seth lo viene a sapere e, scoperto il nascondiglio della cassa, in un impeto di rabbia fa scempio del corpo del fratello, dividendolo in quattordici pezzi che poi sparpaglia per tutto l’Egitto.
Ma Seth lo viene a sapere e, scoperto il nascondiglio della cassa, in un impeto di rabbia fa scempio del corpo del fratello, dividendolo in quattordici pezzi che poi sparpaglia per tutto l’Egitto.
Iside allora assume la forma di nibbio e vola sull’Egitto alla ricerca dei pezzi. Li ritrova tutti tranne uno, il fallo, che è caduto nel Nilo ed è stato mangiato dai pesci.
Con l’aiuto del dio Thoth Iside rimette insieme i pezzi del suo sposo, e con lo scopo di farlo vivere nuovamente li unge con balsami preziosi e li avvolge in garze, inventando il rituale dell’imbalsamazione. Al posto del pene mette un fallo d’oro che lei stessa ha modellato.
Terminato il rituale, Osiride risorge e diviene il re degli Inferi. Il suo corpo e quello di Iside si sollevano insieme nel cielo e i due si uniscono un un amplesso sacro da cui nascerà Horus.
Con l’aiuto del dio Thoth Iside rimette insieme i pezzi del suo sposo, e con lo scopo di farlo vivere nuovamente li unge con balsami preziosi e li avvolge in garze, inventando il rituale dell’imbalsamazione. Al posto del pene mette un fallo d’oro che lei stessa ha modellato.
Terminato il rituale, Osiride risorge e diviene il re degli Inferi. Il suo corpo e quello di Iside si sollevano insieme nel cielo e i due si uniscono un un amplesso sacro da cui nascerà Horus.
Seth, che ora è il re d’Egitto, non deve sapere della nascita di Horus, altrimenti cercherebbe di ucciderlo. E’ così che inizia il viaggio avventuroso di Iside e di suo figlio attraverso l’Egitto, in cerca di riparo e protezione.
Quando Horus diviene adulto e abbastanza potente, sfida e sconfigge lo zio assassino, ma Iside gli chiede di risparmiargli la vita: dopotutto, è sempre suo fratello.
Horus diviene il nuovo re d’Egitto e Iside scoppia di gioia per questo. Canta inni e piange lacrime dorate. Alcuni miti narrano che, una volta divenuto re, Horus sposa sua madre, che diviene a sua volta madre dei suoi quattro figli.
Horus diviene il nuovo re d’Egitto e Iside scoppia di gioia per questo. Canta inni e piange lacrime dorate. Alcuni miti narrano che, una volta divenuto re, Horus sposa sua madre, che diviene a sua volta madre dei suoi quattro figli.
In questa storia ci appaiono alcuni dei mille volti di Iside: Iside la sposa fedele, l’innamorata coraggiosa che per ben due volte parte alla ricerca dell’amato e in entrambi i casi lo ritrova; Iside la sciamana, la dea alata che raccoglie i pezzi sparsi dell’anima di Osiride e li rimette insieme, risvegliandolo a nuova vita; Iside madre e moglie, moglie e madre, protettrice e donatrice di vita (è madre e moglie di Horus ma in un certo senso è moglie e madre anche di Osiride, che fa rinascere come re degli Inferi).
sabato 4 maggio 2019
La terribile origine del termine "puttana"
L’etimologia risale al alto Medio Evo, ai tempi delle crociate.
Quando gli uomini partivano per la Palestina a massacrare donne, vecchi e bambini.
Le donne, spesso rimanevano sole a casa, lasciate al totale abbandono e senza risorse, indifese da tutto. Va detto che in quel periodo, una donna che uccideva un uomo anche solo per difendere la propria vita, nel 100% dei casi veniva condannata a morte.
Per tanto va da se che ogni violenza, ogni atto di brutalità commesso nei loro confronti, rimaneva impunita.
Il termine “Puttana” sta ad indicare una parola d’origine a cui fu accomunata erroneamente e arbitrariamente un tipo di donna ossia, la prostituta.
Nell'uno come nell'altro caso, la violenza era la costante che caratterizzava allora come oggi l’atto vile dello stupro.
Dovete sapere che la parola deriva da “Putto” ossia bambino e che nulla a che vedere con altre questioni se non questa.
Quando le povere sventurate rimanevano da sole era facile che dei “Pellegrini”, pernottassero nelle loro case, e che questi non approfittassero solo dell’ospitalità ma, anche della donna stessa, stuprata e quasi sempre messa incinta, ella era obbligata a disfarsi dei bambini nati vendendoli ai signorotti o ai viandanti che cercavano schiavi sessuali il più delle volte.
Quindi due volte vittime.
La donna che subiva lo stupro e da esso aveva un figlio, era obbligata a venderlo per mantenere anche quelli dell’imbecille che era partito per andare a compiere massacri in Palestina con la speranza di tornare a casa e avere come riconoscimento del suo ignobile operato, un piccolo feudo o una ricompensa dalla fottuta “Chiesa cattolica”.
Come dicevo, le donne erano oggetto di ogni tipo di violenza, sia fisica che psicologica, nessuno ne prendeva le parti, nessuno puniva i loro aguzzini e questo, perché c’era l’assurda convinzione la donna fosse portatrice del “Peccato originale” e che per questo meritasse ogni forma di umiliazione.
mercoledì 1 maggio 2019
Il Sorbo (Luis) è il secondo albero dell’alfabeto arboreo celtico
Il Sorbo (Luis) è il secondo albero dell’alfabeto arboreo celtico e i suoi rami rotondi, coperti di pelli di toro appena scuoiato, erano usati dai druidi come estrema risorsa per incitare gli spiriti a rispondere a domande difficili. Nelle isole britanniche, il Sorbo è l’albero più utilizzato come protezione contro i fulmini e i malefici in genere.
Nell’antica Irlanda i druidi di due eserciti nemici accendevano fuochi di Sorbo e vi recitavano sopra incantesimi per chiamare gli spiriti a prendere parte al combattimento. Nell’epica celtica (Il Romanzo di Diarmuid e Grainne) la bacca del Sorbo, insieme alla mela e alla noce rossa, viene definita “cibo degli dei”, espressione che porta a interpretare il tabù alimentare su tutto ciò che è rosso come un’estensione di quello comune sul fungo rosso dell’Amanita muscaria, considerata “cibo degli dei” anche presso Greci e Romani (nella Grecia antica tutti i cibi di colore rosso -aragoste, pancetta, triglia, gamberi, frutta e bacche rosse – erano soggetti a tabù tranne che nelle festività in onore dei morti. Il rosso, forse anche per l sua connessione con il colore del sangue, era il colore della morte in Grecia e nella Britannia dell’Età del Bronzo, come mostra l’ocra rossa rinvenuta nelle sepolture megalitiche della piana di Salisbury, così come in altre sepolture dell’Europa Neolitica – cfr. M.Stone, Quando Dio era una donna).
Il Sorbo è considerato dai Celti l’albero del ritorno in vita e del risveglio, profondamente legato al prevalere della luce sul buio. Il suo mese nel calendario celtico va dal 21 gennaio al 17 febbraio, e a metà di questo periodo cade la festa di Imbolc (1 febbraio), una delle quattro feste stagionali che scandivano l’anno pagano (insieme a Beltane, Lammas e Samain). Imbolc è la festa del ritorno della luce, segna la fine dell’inverno e l’inizio della rinascita della vegetazione. Imbolc e il Sorbo sono protetti dalla dea Brigid (o Birgit, Brigitta, Brigantia), divenuta poi con il Cristianesimo Santa Brigida, che un tempo era la Dea Bianca, la Triplice Dea protettrice del Fuoco, del risveglio alla vita, delle arti, della filatura e della tessitura. Anche per questa ragione, tradizionalmente, i fusi erano in legno di Sorbo. Il legame tra il Sorbo e il Fuoco, la Luce, si trova anche nel suo nome celtico: Luis, che ha la stessa etimologia di luisiu, ovvero “fiamma”.
Le bacchette da rabdomante un tempo usate per trovare i metalli erano in legno di Sorbo e il suo legno veniva spesso usato nella divinazione. Il suo uso oracolare spiega forse, secondo Graves (Graves R., La Dea Bianca) la presenza di boschetti di quest’albero a Rugen e nelle altre isole baltiche dell’ambra, un tempo sedi oracolari, nonché la frequente ricorrenza del Sorbo notata da John Lightfoot (Lightfoot J., Flora Scotica) nei pressi di antichi cerchi di pietre. Il Sorbo era considerato protettore delle soglie e portatore di luce, custode del passaggio tra i mondi e dei risvegli a nuova vita.
Nei miti norreni ritroviamo ancora il Sorbo come simbolo di protezione. Un mito islandese narra che Thor, dio dei tuoni e dei fulmini, un giorno stava per annegare in un fiume, ma riuscì a salvarsi aggrappandosi a un ramo di Sorbo. Da allora, oltre alla Quercia, anche il Sorbo divenne sacro al dio. Poiché Thor è il dio dei fulmini, questo spiegherebbe anche come mai il Sorbo è considerato nel nord l’albero che meglio protegge contro di essi (statisticamente, quest’albero è in effetto uno dei meno colpiti durante i temporali).
Tradizionalmente, nel Galles avere un Sorbo vicino alla propria casa era considerata una fortuna e le donne si appuntavano al petto bacche di Sorbo per proteggersi dalle stregonerie.
Infine, è interessante notare come in molte leggende irlandesi si trovino serpenti e draghi in qualità di guardiani di alberi di Sorbo, ed essendo il serpente uno degli animali-simbolo della Grande Dea nella sua versione ctonia, questo dato ci parla della connessione tra il Sorbo e la Dea così come di quella tra il Sorbo e le forze della Terra. Infatti se consideriamo che molto spesso i cerchi di pietre megalitici sorgono lungo le linee in cui scorrono le correnti energetiche della Terra (una sorta di meridiani del corpo di Gaia, un tempo chiamati “linee del drago”, e il drago non è in fondo che una versione potenziata del serpente che, guarda caso, sputa fuoco), e che spesso vicino a questi siti si rinvengono Sorbi o tracce di essi, vediamo come serpenti, Sorbi e siti megalitici siano legati dal filo rosso del culto della Dea Madre, che altro non è se non il pianeta-organismo su cui viviamo e di cui facciamo parte. Le antiche popolazioni, che intuivano e conoscevano l’anatomia energetica della Terra, costruivano mandala di pietra in luoghi in cui l’energia era particolarmente forte, per favorire la comunicazione tra i mondi, le dimensioni temporali e i piani di coscienza, e ponevano il Sorbo come guardiano di questi portali.
Il rito di Beltane
Il rito di Beltane (il Maggio della tradizione contadina) è la festa più importante dopo Samonios, poiché determina l’inizio della metà luminosa dell’anno, dedicata al Dio maschile: è il trionfo dell’amore sessuale, della fecondità, della luce e del conscio.
Tutta la natura è ormai in fiore, impegnata nella fecondazione e nella proliferazione. Il rito, che prevede l’accensione di uno o più falò, è incentrato ovviamente intorno al potere trasformante del fuoco e ruota intorno alla figura mitica della Fanciulla dei Fiori. Ella accoglie il Maponos, il Fanciullo Divino incarnazione della giovane virilità maschile che con Lei si accoppia per assicurare abbondanza materiale e spirituale alla tribù (lui) insieme alla Terra (lei). Si rinnova il matrimonio sacro. Altri temi collegati sono la sconfitta del Gigante Biancospino, rappresentante le forze caotiche e distruttive della natura, e il potere di guarigione del fuoco (maschile) nell’acqua (femminile).
La Dea Eostre nei culti primaverili
L’Equinozio di Primavera, come quello d’autunno, è uno dei due momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio (la parola equinozio deriva dal latino “aequus nox”, notte uguale). Astronomicamente l’equinozio di primavera (chiamato anche Vernale) è il momento in cui il sole si trova al di sopra dell’equatore celeste. L’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno e quello di primavera l’esatto opposto: è l’inizio della metà luminosa, quando le ore di luce superano le ore di buio. E’ il primo giorno della primavera, la stagione della rinascita, associata presso varie culture a concetti come fertilità, resurrezione, inizio.
Le antiche tradizioni ci offrono infatti tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a cui succede una rinascita. Un mito che mostra bene l’idea di un sacrificio e di una successiva rinascita è quello frigio di Attis e Cibele: Attis, bellissimo giovane nato dal sangue della dea Cibele e da questa amato, voleva abbandonarla per sposare una donna mortale. Cibele lo fece impazzire ed egli si evirò morendo dissanguato. Dal suo sangue nacquero viole e mammole. Gli dei, non potendolo resuscitare, lo trasformarono in un pino sempreverde. Dopo l’Equinozio, si svolgevano nel mondo ellenico le Adonìe, feste della resurrezione di Adone, bellissimo giovane amato dalla dea Afrodite che venne ucciso da un cinghiale (forse il dio Ares ingelosito).
Adone era in realtà il dio assiro-babilonese Tammuz, a cui i fedeli si rivolgevano chiamandolo “Adon” (Signore). Egli dimorava sei mesi all’anno negli inferi, come il sole quando si trova al di sotto dell’equatore celeste (autunno e inverno). Si festeggiava a primavera la sua risalita alla luce quando si ricongiungeva alla dea Ishtar, l’equivalente dell’Afrodite greca. Allo stesso modo si festeggiava Persefone che ritorna nel mondo dopo aver trascorso sei mesi nel regno dei morti.
Tutti questi miti ci mostrano l’unione di un simbolismo celeste (il cammino del sole nel cielo) e un simbolismo terrestre (il risveglio della Natura) in cui riecheggia il tema del matrimonio fra una divinità maschile, celeste o solare, ed una femminile, legata alla terra o alla luna. La primavera era infatti la stagione degli accoppiamenti rituali, delle nozze sacre in cui il Dio e la Dea (personificati spesso da un sacerdote e da una sacerdotessa) si accoppiavano per propiziare la fertilità.
Venivano accesi dei fuochi rituali sulle colline e, secondo la tradizione, che peraltro è rimasta ancora oggi nel folklore europeo, più a lungo rimanevano accesi, più fruttifera sarebbe stata la terra. Questi riti avevano un particolare valore soprattutto nel paganesimo dell’area mediterranea dove già all’equinozio il ritorno della bella stagione e il rinnovarsi della natura è evidente. Per i popoli nordici, come i Celti, la ricorrenza primaverile più importante era Beltane che si celebrava nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio.
Come molte delle antiche festività pagane, anche l’Equinozio di Primavera fu cristianizzato: la prima domenica dopo la prima luna piena che segue l’Equinozio (data fissata nel IV°secolo D.C.), i cristiani celebrano la Pasqua commemorando la resurrezione di Cristo avvenuta proprio durante la festività ebraica così denominata che ricorda l’esodo del popolo di Israele dall’Egitto. Ma nei simboli e nelle tradizioni collegate a questa festa sono evidenti i ricordi di altre e ben più antiche festività poi cancellate dal Cristianesimo con una vera e propria opera di sincretismo.
Il termine “Easter” con cui in inglese si designa la Pasqua ci riporta ad una antica divinità pagana dei popoli nordici, la dea Eostre, assimilabile a Venere, Afrodite e Ishtar, la quale presiedeva ad antichi culti legati al sopraggiungere della primavera e alla fertilità dei campi. I popoli Celti denominavano l’equinozio di Primavera “Eostur-Monath” e successivamente “Ostara”. Il nome sembrerebbe provenire da aus o aes e cioè Est, e infatti si tratta di una divinità legata al sole nascente e al suo calore. E del resto il tema dei fuochi e del ritorno dell’astro sarà un tema ricorrente nel prosieguo delle tradizioni pasquali.
A Eostre era sacra la lepre, simbolo di fertilità e animale sacro in molte tradizioni. I Britanni associavano la lepre alle divinità della luna e della caccia e i Celti la consideravano un animale divinatorio.
Si dice che i disegni sulla superficie della luna piena raffigurino una lepre, ricordo questo dell’associazione dell’animale con divinità lunari. Questa raffigurazione della “lepre nella luna” appare nelle tradizioni cinesi, europee, africane e indiane. Nella tradizione buddhista le leggende narrano di come una lepre si sacrificasse per nutrire il Buddha affamato, balzando nel fuoco. In segno di gratitudine il Buddha impresse l’immagine dell’animale sulla luna. In Cina la lepre lunare ha un pestello ed un mortaio con cui prepara un elisir di immortalità. Gli Indiani Algonchini adoravano la Grande Lepre che si diceva avesse creato la Terra. Nell’antica Europa i Norvegesi rappresentavano le Divinità lunari accompagnate da una processione di lepri che portano lanterne. Anche la Dea Freya aveva come inservienti delle lepri e la stessa Dea Eostre era raffigurata con una testa di lepre.
La lepre di Eostre, che deponeva l’uovo della nuova vita per annunciare la rinascita dell’anno, è diventata l’odierno coniglio di Pasqua che porta in dono le uova, altro simbolo di fertilità. Così le uova pasquali si ricollegano alle tradizioni pagane in cui si celebrava il ritorno della dea andando a scambiarsi uova “sacre” sotto l’albero ritenuto “magico” del villaggio, usanza che collega Eostre alle divinità arboree della fertilità. E l’uovo non è scelto a caso ma è da sempre simbolo di vita, di creazione, di rinascita.
Per il primitivo raccoglitore e cacciatore la primavera portava gli uccelli a deporre le proprie uova e dunque ad avere un nuovo sostentamento dopo l’austerità dell’inverno. E la nascita del mondo da un uovo cosmico è un’idea universalmente diffusa che veniva celebrata presso molte civiltà alla festa equinoziale di primavera, quando la natura risorge. Infatti in numerose mitologie un uovo primordiale, embrione e germe di vita, è il primo essere ad emergere dal Caos: è l’”Uovo del mondo” covato da una Grande Dea e dischiuso dal Dio Sole.
Un mito dell’India narra che nella notte dei tempi tutto era immerso nelle tenebre e sepolto in un sonno profondo. L’Assoluto volle creare il cosmo dalla propria sostanza, così creò le acque e vi depose a galleggiare un uovo splendente il quale generò al proprio interno Brahma, il Creatore, che divise poi l’uovo stesso in due parti, formando la terra e il cielo.
Iscriviti a:
Post (Atom)